Visite Guidate
Visite Guidate in evidenza
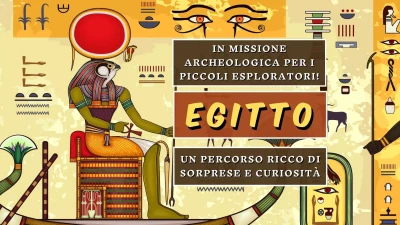
Il meraviglioso Egitto per bambini
Se vuoi fare vivere un'avventura alla "Indiana Jones" al nostro giovane ospite prenota questa visita.
Storia
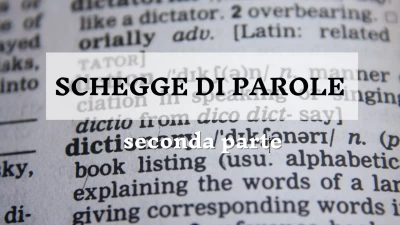
Geoparemiologia, oratorio riscoperto, strane storie, un errore giudiziario, muro a secco. Un mucchio di cose.

Davidsohn dedicò oltre quarant'anni della sua esistenza a un instancabile lavoro di ricerca documentaria.

Un'esperienza emozionante esplorare il cimitero ebraico di Pitigliano. Da vedere.












