Simone Martini, pittore
Simone Martini
Simone Martini, noto talvolta come Simone Senese (Siena, circa 1284 - Avignone, 1344), è senza dubbio considerato uno dei maestri della scuola senese e uno dei più importanti e influenti artisti del Trecento italiano, in grado di competere con Giotto per il primato. La sua formazione avvenne molto probabilmente nella bottega di Duccio di Buoninsegna.
Alla fine del Duecento e nei primi anni del Trecento, la pittura senese era fortemente influenzata dal grande maestro Duccio di Boninsegna, il cui stile era radicato nella tradizione bizantina, ma ne assorbiva tutte le essenze senza cercare ispirazioni altrove. Le sue opere si caratterizzavano per l'uso di ampie aree di colore, intense ma serene, supportate da linee sobrie e austere. In alcuni casi, sembrava che i suoi dipinti fossero realizzati con la tecnica degli smalti cloisonnés, con chiare divisioni riempite di paste vitree fuse e poi raffreddate. Nonostante ci fosse un leggero richiamo all'opulenza orientale, il suo lavoro era intriso di una trama sottile e raffinata. I suoi discepoli cercarono di emularne lo stile, ma fu Simone Martini a riuscire a cogliere appieno quell'intensità raffinata e a farla diventare il fondamento della sua originalità.
II
Nel 1315, quando Simone dipinse la "Maestà", una grande Madonna in trono circondata da numerosi santi (vedi Figura 1), aveva circa trentadue anni. Questa è la sua prima opera pervenutaci, quindi non conosciamo nulla del suo periodo formativo precedente. Tuttavia, possiamo già affermare che la sua formazione artistica derivava da Duccio, e ciò è un indicatore della sua notorietà. Se non fosse stato uno dei primi pittori di Siena, il Comune non gli avrebbe affidato l'incarico di realizzare il più monumentale affresco nella sala più importante del Palazzo Pubblico. Questo affresco raffigurava il gesto devoto di dedicare la città a Maria Vergine, una pratica che Siena, conosciuta come "vetus Civitas Virginis", compiva ritualmente all'inizio di ogni sua impresa, che si trattasse di promulgare leggi, dichiarare guerre o costruire un nuovo palazzo. Tre anni dopo, lo troviamo a Napoli alla corte di Re Roberto, dove era il pittore ufficiale e retribuito della corte, realizzando diverse opere, alcune delle quali ora perdute, ma tra cui il ritratto di San Lodovico, fratello del re (1328, Figura 7), la "Annunciazione" per il Duomo (1333, ora alla Galleria degli Uffizi, Figure 8-11) e la tavola del beato Agostino Novello a San Agostino (Figure 12-14).
Tra il 1320 e il 1328, lavorò a Pisa per l'Ancona di Santa Caterina, che oggi è divisa tra il museo e il seminario; ad Orvieto per vari lavori; e ad Assisi, dove realizzò la sua opera più vasta, la decorazione della cappella di San Martino (Figure 3-6). Durante questo periodo, alternava questi soggiorni con residenze a Siena, ma dal 1328 al 1335, rimase a Siena per gran parte del tempo, diventando quasi il pittore ufficiale della città. Dipinse diverse opere per il Comune e le chiese, tra cui il ritratto di Guidoriccio da Fogliano, capitano vittorioso (1328, Figura 7), l'"Annunciazione" per il Duomo (1333, ora agli Uffizi, Figure 8-11), e la tavola del beato Agostino Novello a San Agostino (Figure 12-14).
Nel 1335, mentre lavorava alla porta Camollia a Siena, ricevette un invito da Benedetto XII per recarsi ad Avignone. Benedetto stava cercando i migliori artisti in Italia per decorare la sua sede in esilio e aveva contattato anche Giotto, che aveva realizzato l'opera famosa nell'Oratorio. Simone Martini accettò l'invito e da allora non tornò più a Siena, poiché morì ad Avignone nel 1344. Sebbene gli affreschi che aveva realizzato per il palazzo papale e a Nótre Dame-des-Doms siano andati perduti, possiamo vedere il suo livello artistico in opere come il "Ritorno di Gesù dalla disputa" a Liverpool (1342, Figura 15), il polittico di Anversa (Figura 16, frammentato, con alcune parti al Louvre, Figura 17), e l'"Annunciazione" Stroganoff (Figura 18).
Ad Avignone, Simone incontrò il poeta Petrarca e divenne suo amico. Gli dipinse il ritratto di Laura, come testimonia il celebre sonetto di Petrarca, e illustrò il codice virgiliano in cui il poeta scrisse:
Mantua Virgilium qui talia carmina finxit
Sena tulit Symonem digito qui talia pinxit (1)
Questo distico potrà non essere perfetto, ma rappresenta una toccante testimonianza tangibile di legami tra due antichi artisti che amiamo. Oltre a quanto citato, rimangono poche altre opere di Simone Martini.
III
Questi elementi testimoniano la grandezza di Simone Martini. Mentre il favore della moda può essere effimero e ingannevole, la riconoscenza della storia difficilmente sbaglia. Simone Martini è una grandezza che si è meritato. La sua grandezza non è solo frutto della tradizione in cui è cresciuto, purificata e perfezionata attraverso secoli di pratica stilistica, ma anche del suo talento naturale. Di fronte all'arte, non può sbagliare. Anche quando dipingeva scene lodevoli e narrative richieste dalla Chiesa, come i dipinti della Vergine e delle storie dei santi, non ha mai compromesso la chiarezza del suo disegno. Come un vero erede della tradizione bizantina, le sue opere sono caratterizzate da linee e colori che si sviluppano con una semplicità melodiosa e una gioia di pause, che rende le riprese, anche se estremamente delicate, più vive e nitide. Le sue linee seguono cadenze nobilmente sostenute e le esaurisce fino alla fine delle loro possibilità senza mai romperle in collisioni inattese o complicarle con intrecci drammatici. La sua tecnica meticolosa è una forma di lirismo acceso. Le sue sagome sono tra le più raffinate mai realizzate, e in alcune opere, i colori sono puri e indipendenti, come era stato insegnato da Duccio. Utilizza toni come il rosso, il verde e l'azzurro, spesso con pochi contrasti interni di chiari e scuri, definiti chiaramente al limite di ciascuna zona, in modo che seguano docilmente il percorso come due campi separati da un fossato di confine che non si toccano mai. A volte, introduce innovazioni cromatiche di grande leggerezza, colori eterei privi di sostanza, come il viola, l'azzurro e il grigio cenere.
Luigi Dami. (1882 – 1926), critico e storico dell'arte italiano.
Luigi Dami Tratto da Simone Martini, Piccola collezione d'arte, Firenze, Istituto edizioni artistiche, 1921
(1) Il ritratto di Laura è stato sfortunatamente perso, tutto ciò che rimane della misteriosa Laura sono i due sonetti di Petrarca, in cui il poeta elogia il talento divino dell'artista

Particolare, Il miracolo della Resurrezione di un bambino (1284-1344, Italy)
Cappella di San Martino

San Ludovico di Tolosa che incorona il fratello Roberto d'Angiò
Museo nazionale di Capodimonte, Napoli

Predella di San Ludovico che incorona il Fratello Roberto d'Angiò
Museo nazionale di Capodimonte, Napoli
Cappella di San Martino (Assisi)

Simone Martini, dettaglio dall'Investitura di san Martino a cavaliere

San Martino divide il mantello con il povero

Apparizione di Cristo e angeli in sogno a san Martino

Messa miracolosa in cui angeli coprirono le braccia del santo sprovviste di mantello (donato ad un povero)
Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi
Palazzo Pubblico di Siena, Siena

Firmata e datata al 1333, e
conservato negli Uffizi



L'Angelo

La Vergine
"Beato Agostino Novello e storie”, dipinto autografo di Simone Martini,1328
custodito nella chiesa di Sant’Agostino, Siena


Miracoli del beato Agostino, di Simone Martini
“Sacra Famiglia”,Simone Martini, 1342, Walker Art Gallery di Liverpool.

Il Polittico Orsini di Simone Martini
Oggi si trova disperso in musei di Anversa, Parigi e Berlino.

Particolare dell'Andata al Calvario
Conservato oggi al Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anversa.

Particolare dell'Andata al Calvario
Musée du Louvre, Parigi
Maria Vergine annunciata
Museo dell'Ermitage (Gosudarstvennyj Eremitage), San Pietroburgo (?)
Ex Collezione G. Stroganoff, Roma

Particolari della Maestà di Simone Martini, 1315, situato al Palazzo Pubblico di Siena.



Altri articoli

Robert Davidsohn, una vita per la storia
Davidsohn dedicò oltre quarant'anni della sua esistenza a un instancabile lavoro di ricerca documentaria.
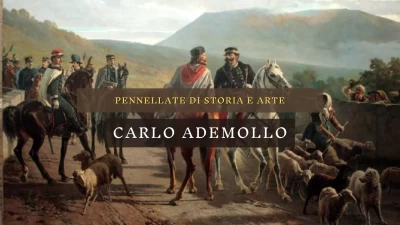
Carlo Ademollo, pittore
Dalla Tela all'Anima. Dipinti di Passione Storica: Le opere di Ademollo come testimonianze emozionanti della storia italiana.
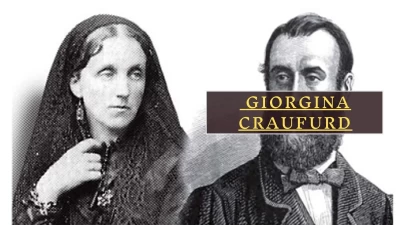
Giorgina Janet Craufurd
Insieme a marito, condivise e lottò per l'unificazione italiana, partecipando attivamente al Partito d'Azione e sostenendo il genarale Garibaldi.
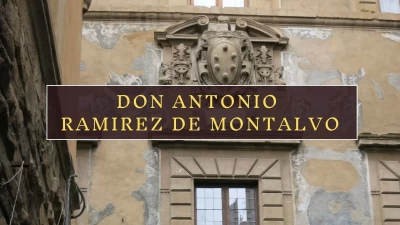
Don Antonio Ramirez de Montalvo
Contribuì all'ascesa politica del granduca, mentre Eleonora di Toledo ha consolidato legami tra le potenti famiglie spagnola e medicea.

